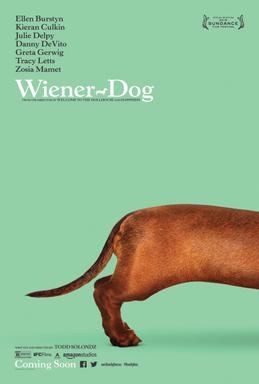Mia è un'aspirante attrice che ha perso la fiducia in se stessa, Sebastian un virtuoso pianista che sogna di aprire un locale jazz ma è invece costretto ad allietare la clientela con dozzinali canzoni natalizie per sbarcare il lunario.
«Dedicato ai folli e ai sognatori» recita una Tagline del film, perché chi è tanto pazzo da inseguire i suoi sogni spesso non sopravvive alla realtà (il testo di "Audition"). E come diceva Nietzsche "l'arte rende insopportabile la vista della vita".
Il film dedica se stesso un po' a questo concetto, indaga i confini labili fra realtà e finzione e lo fa servendosi del genere che più di tutti gli altri ha storicamente evaso la realtà sensibile, esaltandone la dimensione onirica, surreale, magica per riscrivere con l'Arte le regole di quella stessa realtà che l'ha originata e piegata.
Spesso lo ha fatto con vena polemica nei confronti del business e di quella, quasi contraddittoria, tendenza della realtà a ricreare in arte (e quindi anche in musica e nel cinema) quella fantasia che all'interno di sé invece soffoca; Chazelle parla anche di questo.
Un film sulla bellezza imprescindibile dei sogni, ma al contempo sull'importanza di guardare avanti: se in Whiplash l'ideale di perfezione (la mimesi arte-realtà) guidava e trasfigurava la realtà offrendo un mix significativo di sangue e leggenda, di corporeo ed etereo, qui Chazelle, nonostante le colorate pennellate di allegria che inevitabilmente segnano un film diverso, ricorda in sottofondo come la realtà sia dura e inclemente nei confronti delle illusioni dei sognatori, di come spezzi chi tenta di salire la grande scala del successo, ma anche che il segreto di tutto è che in fondo siamo nati per essere quello che siamo e che l'autodeterminazione del sogno non può prescindere dalla conquista di una realizzazione reale, salda a terra (il sacrificio e l'applicazione in Whiplash, la rinuncia ad un pezzo del sogno stesso qui: viene citato Casablanca, in cui per fare la cosa più giusta i due protagonisti si separano).
Chazelle porta il Jazz in un Musical; non per la prima volta - certo - ma in un modo che è tutto suo che conferma lo straordinario legame simbiotico e quasi biologico del regista con le sue profonde radici (è uno stile di vita, un'entità che si intromette nella vita e la rimodella di minuto in minuto, ed è l'immaginario romantico fatto di leggende e concretezza che anche qui vengono alimentate) e serve da metafora per quello che qui realizza: prendere un Genere tradizionale o tradizionalista, composto di una serie di inesorabili convenzioni e ammiccamenti classici e, in qualche modo, sovvertirle una per una per poi reinventarle con occhi nuovi ("give us new colors to see").
Si potrebbe quasi dire che Chazelle ha diretto un Musical come un formidabile solista jazz: la sua passione, l'energia con la macchina da presa (long-take, interi piani-sequenza come quello introduttivo, carrellate e panoramiche adrenaliniche: lo stile è abbastanza libero e individualista perché dia l'impressione che stia facendo proprio quello che fanno i suoi musicisti: rompere gli schemi del film e inventare qualcosa di sorprendente "out of the blue") sottendono a uno spirito rivoluzionario e irrequieto e, tuttavia, già "classico", già un modello cui ispirarsi successivamente per farne qualcosa di diverso.
Se nella prima parte sistema il detonatore in punta di piedi, con classe ma senza esagerare nelle soluzioni coreografiche, nella seconda attinge finalmente al combustibile emotivo della storia per far esplodere letteralmente il film in una vertigine di luci ipnotizzanti, scenografie immaginifiche, numeri musicali usciti letteralmente dal nulla... la stilizzazione visiva è decisiva per Chazelle, senza non sarebbe se stesso, e il racconto che rimane a lungo un po' ripiegato su qualche prevedibile cliché finisce per acquisire una sua dignità nel volto di altri due personaggi (dopo Whiplash) che si specchiano e scontrano l'uno nell'altro, ricavandone speranze e delusioni, e alla fine, il meritato palcoscenico.
In generale il film traspone bene il sentimento dei suoi personaggi in questa confusa linea immaginaria che li separa fra loro e dai loro alter ego, non cade nella tentazione di voler rifare Broadway, ha un suo stile che lo contraddistingue e un lavoro miracoloso sul dettaglio e sull'impressionismo dei colori sfolgoranti che lo rende allegro senza essere vacuo, che ha qualcosa in più da dire anche sulle vicende sentimentali (mai lasciate a bagno nella scena troppo a lungo) rispetto a una morale che è riuscita non perché attesa ma perché velata da un senso di onestà rispetto ai personaggi e alla loro identificazione con le persone che li hanno scritti.
Le musiche sono ora classicheggianti ora completamente insolite (in una parola "versatili"), implementando nel sontuoso lavoro di Hurwitz sia elementi della tradizione teatrale che quelli di più diretta influenza dei circoli esclusivi, i numeri musicali sono copiosi ma mai invasivi, anche se pochi in realtà quelli in grado di lasciare il segno - strategicamente collocati nelle scene chiave.
Il suo valore è comunque già ampiamente dimostrato dalla sfilza di premi ricevuti, e per sapere se otterrà anche quello più ambito della stagione cinematografica è solo questione di tempo.